“Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.” A. Einstein
L’autostima è quel processo soggettivo e duraturo che porta il soggetto a valutare e apprezzare se stesso tramite l’auto approvazione del proprio valore personale fondato su autopercezione. Il senso d’autostima è dato da un mix di derivazioni. Vi è la componente cognitiva, che fa parte del bagaglio delle conoscenze e dell’esperienze dell’individuo. Poi vi è la componente affettiva, che influenza la sensibilità dell’individuo nel provare e nel ricevere sentimenti. E poi ovviamente vi è la componente sociale, che rappresenta l’appartenenza al gruppo e l’annessa possibilità di poter avere influenza sul gruppo e quindi di ricevere approvazione o meno dai componenti del gruppo stesso. Dunque l’autostima corrisponde alla “considerazione che un individuo ha di sé stesso” (Galimberti U. 1999), tale considerazione si esplica tramite un atteggiamento, una valutazione cognitiva o un insieme di affetti rivolti verso il sé.
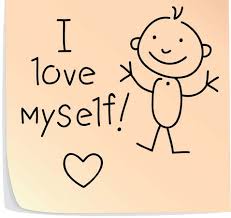 L’autostima è di per certo uno dei segnali più chiari di Benessere Psicologico, dimostrabile il fatto che influisca su aspetti come cognizione, motivazione, emozioni e comportamento. il livello di autostima e la stabilità di tale livello costituiscono variabili fondamentali della personalità. L’autostima si costituisce dunque da una valutazione globale sul Sé e da un insieme di più valutazioni su campi specifici, tante quante sono le aree su cui il soggetto intende misurarsi. L’autostima può avere un aspetto generale ed uno specifico: vi sono fluttuazioni nel livello di autostima che dipendono dagli eventi quotidiani, ma persiste un livello di base al quale l’autostima tende a ritornare, deriva da un rapporto tra le proprie aspirazioni ed i successi/insuccessi realizzati; è certamente strettamente collegata allo stile attributivo di una persona: quel processo cognitivo attraverso il quale si cerca di attribuire una causa agli eventi, di interpretare i fatti che si verificano nell’ambiente. Se attribuisco la responsabilità del mio insuccesso a una situazione specifica, sulla quale ho un certo controllo (es. poco studio) la mia autostima non ne risulterà necessariamente compromessa. Se invece attribuisco l’insuccesso a una causa globale, fuori dal mio controllo (es. per la matematica sono negato, non sono intelligente) la percezione di me stesso sarà molto negativa con una forte incidenza sulla mia autostima.
L’autostima è di per certo uno dei segnali più chiari di Benessere Psicologico, dimostrabile il fatto che influisca su aspetti come cognizione, motivazione, emozioni e comportamento. il livello di autostima e la stabilità di tale livello costituiscono variabili fondamentali della personalità. L’autostima si costituisce dunque da una valutazione globale sul Sé e da un insieme di più valutazioni su campi specifici, tante quante sono le aree su cui il soggetto intende misurarsi. L’autostima può avere un aspetto generale ed uno specifico: vi sono fluttuazioni nel livello di autostima che dipendono dagli eventi quotidiani, ma persiste un livello di base al quale l’autostima tende a ritornare, deriva da un rapporto tra le proprie aspirazioni ed i successi/insuccessi realizzati; è certamente strettamente collegata allo stile attributivo di una persona: quel processo cognitivo attraverso il quale si cerca di attribuire una causa agli eventi, di interpretare i fatti che si verificano nell’ambiente. Se attribuisco la responsabilità del mio insuccesso a una situazione specifica, sulla quale ho un certo controllo (es. poco studio) la mia autostima non ne risulterà necessariamente compromessa. Se invece attribuisco l’insuccesso a una causa globale, fuori dal mio controllo (es. per la matematica sono negato, non sono intelligente) la percezione di me stesso sarà molto negativa con una forte incidenza sulla mia autostima.
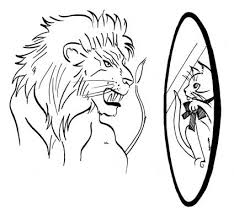 La mancanza di autostima traspare anche da atteggiamenti mentali e azioni che condizionano pesantemente la nostra vita sociale e il nostro benessere psicofisico. Più comunemente l’individuo tenderà a commettere degli errori come ad esempio a spostare la colpa verso gli altri, “Se non fosse stato per i miei genitori ora avrei un lavoro migliore”. “Il matrimonio non funziona per colpa di mia moglie”. Atteggiamento questo, molto frequente, l’insicurezza porta a difendersi costantemente, proiettando all’esterno le proprie responsabilità di fallimento. Disconoscere le difficoltà, quando si attraversa un momento di crisi si tende a rifiutare di riconoscere quanto sta accadendo. Spesso si minimizza o si cerca in modo compulsivo di distrarre la mente dal presente, perché si è spaventati dalla forza dei sentimenti e delle sensazioni che si provano. Se invece si accettano, se ci si ricorda che è una fase passeggera e che come tale è destinata a cambiare, si sarà capaci di affrontare le difficoltà e rimediare alla (momentanea) mancanza di autostima.
La mancanza di autostima traspare anche da atteggiamenti mentali e azioni che condizionano pesantemente la nostra vita sociale e il nostro benessere psicofisico. Più comunemente l’individuo tenderà a commettere degli errori come ad esempio a spostare la colpa verso gli altri, “Se non fosse stato per i miei genitori ora avrei un lavoro migliore”. “Il matrimonio non funziona per colpa di mia moglie”. Atteggiamento questo, molto frequente, l’insicurezza porta a difendersi costantemente, proiettando all’esterno le proprie responsabilità di fallimento. Disconoscere le difficoltà, quando si attraversa un momento di crisi si tende a rifiutare di riconoscere quanto sta accadendo. Spesso si minimizza o si cerca in modo compulsivo di distrarre la mente dal presente, perché si è spaventati dalla forza dei sentimenti e delle sensazioni che si provano. Se invece si accettano, se ci si ricorda che è una fase passeggera e che come tale è destinata a cambiare, si sarà capaci di affrontare le difficoltà e rimediare alla (momentanea) mancanza di autostima.
Nascondere i propri sentimenti negativi non è facile esprimere quello che proviamo, soprattutto se sono emozioni negative, come la rabbia. Ma ostinarsi a non dare voce alle proprie “risonanze”, a non dire mai “No”, non fa altro che peggiorare la nostra mancanza di autostima. Un atteggiamento troppo condiscendente e passivo va corretto con una sana dose di assertività, imparando cioè a difendere i propri diritti e a esprimere serenamente un’opinione di disaccordo quando lo si ritiene opportuno, chiedendo agli altri di modificare i loro comportamenti che ci sembrano fuori luogo o offensivi. Come l’autostima, l’assertività è una capacità che può essere migliorata. Dipendere dalle opinioni altrui, come la coazione a incolpare gli altri, anche la costante ricerca dell’approvazione altrui è sinonimo di un rapporto distorto con l’ambiente sociale e un chiaro segno della mancanza di autostima. Alla base di questi due atteggiamenti c’è la stessa insicurezza e la stessa paura di essere inadeguati, che porta alla sostanziale incapacità di decidere autonomamente.
Per fortuna il cervello umano è dotato di una caratteristica eccezionale: quello che gli psicologi, ma non solo loro, chiamano “adattamento”. Ci sono moltissime forme di adattamento, gli esempi più noti arrivano dal mondo animale: più un essere vivente si adatta all’ambiente in cui vive, meglio è destinato a sopravvivere e quindi ad assicurare la continuità della specie. In psicologia adattamento significa, in poche parole, benessere psicologico. Per questo esistono molti tipi di autostime differenti che, messe tutte insieme, cercano di formare una personalità equilibrata al fine di non puntare tutto su un campo della vita per non rischiare di farsi crollare il mondo addosso quando qualcosa dovesse andare storto su quel versante.
 Lo psicologo William James (1842-1910) è stato tra i primi a studiare un particolare fenomeno: alcune persone con scarse abilità sembravano dotate di una sicurezza di sé ostentata ed incrollabile, mentre altri stimati da tutti e ritenute persone valide diffidano delle proprie qualità.
Lo psicologo William James (1842-1910) è stato tra i primi a studiare un particolare fenomeno: alcune persone con scarse abilità sembravano dotate di una sicurezza di sé ostentata ed incrollabile, mentre altri stimati da tutti e ritenute persone valide diffidano delle proprie qualità.
Ancora oggi riviste, programmi televisivi e libri di auto-aiuto propongono delle “ricette” e dei consigli per migliorare la propria autostima, dando l’illusione che esista una ricetta che vada bene per tutti, dimenticando la componente individuale che ci caratterizza come persone.
Per migliorare la propria autostima è importante lavorare ed occuparsi dei seguenti aspetti
- Scoprire quali sono i propri valori fondamentali e quindi fare chiarezza con se stessi rispetto quello che si vuole e quello che non si vuole nella propria vita.
- Riconoscere le proprie emozioni distruttive: imparare a riconoscere ed entrare in contatto con emozioni maggiormente sane e che ci sostengano nei momenti di difficoltà.
- Lavorare sull’immagine di se: molto spesso ci armiamo di buoni propositi e determinazione (voglio dimagrire, voglio smettere di fumare etc..) ma se prima non modifichiamo l’immagine che abbiamo spesso anche creato di noi stessi tenderemo inconsciamente a sabotarci.
