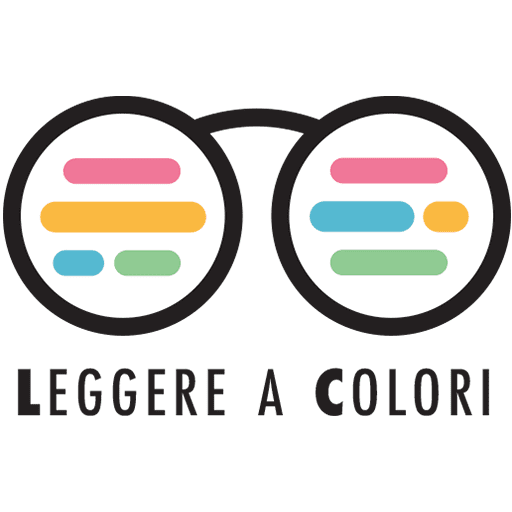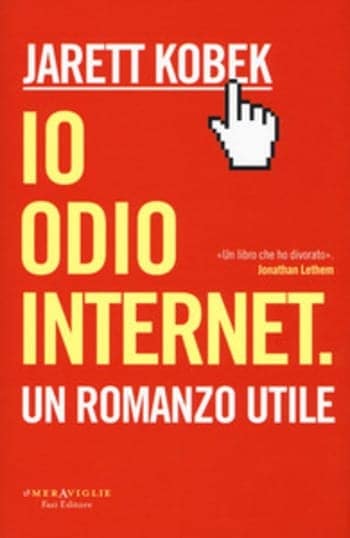 Titolo: Io odio internet
Titolo: Io odio internetAutore: Jarett Kobek
Pubblicato da Fazi - Ottobre 2018
Pagine: 332 - Genere: Narrativa Contemporanea
Formato disponibile: Brossura, eBook
Collana: Le meraviglie
📗 Acquista scontato su ibs.it
📙 Amazon (spedizione gratuita)
📗 eBook su ibs.it
📙 Versione Kindle
Adeline è una “una bella donna adulta, una versione elegante di quelle rockettare sulla quarantina che incontri al Rainbow Room" e che "apre la bocca e sembra una Dianna Vreeland drogata e ha un sacco di opinioni erudite e folli su qualunque argomento. È affascinante. E è più o meno famosa." E perciò "La gente adora guardare le celebrità che si auto-immolano. La gente ne va proprio pazza, accidenti. È lo sport passivo più praticato del nuovo millennio”.
Dì, ma tu hai mai letto Foster Wallace? E allora…
Eh, mi verrebbe da dire, ma non siamo nel mille e novecento novanta e sei. Uno, nove nove sei, come canterebbero gli Afterhours di “hai paura del buio?” ; “sei borghese, offenditi!” si, gli risponderei, ancora di più leggendo questo romanzo. Sempre nell’uno nove nove sei, Palahniuk ha dato alle stampe Fight Club (ricordatevelo per l’approfondimento).
Ma tornando a noi: si, l’ho letto Foster Wallace.
Dove voglio arrivare? Aspettate e vedrete.
Prima di tutto parliamo dello stile, che è il vero punto focale, quello che forse più mi ha indispettito. L’alternativismo nevrotico da studentessa di arti performative che parla come un cartone animato per adulti di Ralph Bakshi (opera prima 1972) già dieci anni fa è stato ampiamente superato (figuratevi oggi). Mi sto riferendo a quella scrittura tipica della new age americana, molto pop-oriented, molto MTV but cultural-addicted, very skinny young, che si brucia al fuoco di Warhol e lo trascina dagli anni sessanta fin a qua ma ridotto a un lumicino da cimitero; sarà pure limite mio grande, ma fatico non solo a comprenderne la forma, ma addirittura a concepirla. SOPRATTUTTO nel duemila e diciotto. Questo stile rispecchia un rigurgito proto-punk-giovanile da preistoria dell’etere, quando ancora ci si colorava i capelli a porcospino e si ascoltava la Jungle. Gli autori che sposano questo modo di scrivere (perché lo possono fare, eh, siamo in un mondo libero, ma se ne assumano la responsabilità) dovrebbero riuscire a capire che l’arguzia, come la comicità, è un’arma pericolosa. Per capirci: una barzelletta raccontata ad un amico seduti sopra la panca d’un pub, fa ridere, soprattutto alla seconda birra. Ma se la sposti su un palco d’un teatro, c’è rischio possa essere avvilente! Perché il rapporto fra spettatore e attore, si muove su meccaniche naturalmente differenti da quello di interlocutore e interloquente. (Non citatemi Colorado, per l’amor del Signore).
Esplico:
«Il punto è», sosteneva J. Karacehennem, il cui cognome in turco significava ‘inferno nero’, «che abbiamo passato, quanto?, due o tre secoli a spaccarci la testa sull’esistenzialismo, che in realtà è solo un modo per chiederci: “Perché siamo su questo pianeta?”, “Perché la specie umana si trova proprio qui?”, “Perché viviamo le nostre esistenze senza senso?”. Tutti i più grandi filosofi e scrittori hanno cercato di rispondere a queste domande e tutti i più grandi filosofi e scrittori non sono riusciti a fornire una risposta convincente. La cosa straordinaria di Facebook è che finalmente capiamo perché siamo nati in una certa città, perché ci fidanziamo, perché consumiamo i nostri stupidi pasti, perché ci chiamiamo in un certo modo, perché possediamo le nostre macchine idiote e perché cerchiamo di fare colpo sui nostri amici. Perché siamo qui, perché facciamo tutte queste cose? Finalmente abbiamo una risposta. Siamo sulla Terra per rendere più ricchi Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg. Le nostre fatiche hanno un senso reale e tangibile. In realtà ciò che sto cercando di dire, credo, è che c’è sempre speranza».
Probabilmente, sulla panca di un pub, questa intuizione aveva del geniale. Poiché sorseggiando vino rosso da un cartone e sistemandosi il basco, blaterando della letteratura autentica, del “mestiere del romanziere”, delle giacche di tweed, e delle pastorali di Philip Roth, tutte le intuizioni su una panca di un pub hanno del geniale, soprattutto più o meno intorno alle due della notte; probabilmente i tannini aiutano a sentirsi molto scomodi per il pudore comune, il pudore di “noi altri alto borghesi di buona famiglia” che ancora ci indigniamo quando ci viene offesa la morale pubblica da questo cinismo à-là-Foster Wallace, nevvero?
Ebbene, io ho letto Foster Wallace. E mi è pure quasi piaciuto Foster Wallace, nonostante non sia il mio genere, perché aveva qualche cosa da dire, un’ottima mano e un buonissimo intuito. Ma come ogni buon proposito religioso, il problema non sta nella filosofia, ma nei discepoli. E dunque questa schiera d’aragoste operose, camicie a quadri e bandane, flanella e vans, col culto estetico per quella trasandatezza ragionatissima, pensano forse d’esser molto perspicaci nel loro compito di erodere i pilastri dell’educazione alto borghese, svelando quei meccanismi occidentali che ci hanno ridotto a meri standard commerciali.
Possibile che io non l’abbia mai vista a questo modo? Come ho fatto ad esser così cieco. Parlamene ancora. Redimimi.
Chiedo scusa, non volevo sprecare caratteri in invettive, ma me l’hanno tirato fuori, torno alla storia. Quale sia è nebuloso. Sta sottotraccia, nuota nel torbido di mezze tirate contro una establishment da pamphlet terrapiattista, storie accessorie, accennate, scorrette ma mai oltre il limite di una seconda serata in compagnia delle Iene (Ilary Blasi, non Tarantino, anche se a Kobek piacerebbe pensare di poter accostarsi al secondo). Prendiamo, ad esempio, la storia dell’Eumelanina, ovvero del pigmento epiteliale simbolo del retaggio di Jeremy Winterbloss (nero africano-americano); un retaggio figlio, a quanto si legge, di una sequela di stupri tra padroni bianchi e donne di colore schiave, roba di antenati che si son dati dispiaceri gli uni agli altri e noi, giovani apatici, ne siamo il risultato, al crocevia della storia, dove son pervenuti i contrari, e noi non sappiamo a chi credere, ma non ci importa granché. (Ma per questi disagi tipici della generazione X, andare a cinque anni prima dell’uno nove nove sei, e chiamare K.C., chiedere di IN UTERO).
Di nuovo, perdonatemi. Dicevamo? La storia. Adelina, la protagonista, è una ex Daria very very alternativa, che con Jeremy (il prima citato simbolo del sincretismo etnico della grande ‘merica), nel suo passato giovanile è stata autrice di un fumetto very very alternativo, di un gatto antropomorfo very very apatico (Fritz The Cat… ah no, quello è Bakshi 1972, questo si chiamava Felix Trill). E ben, dopo una conversazione con tale Kevin Killian accetta il suo invito all’MFA Program del California College of Art per tenere una conferenza davanti ai suoi studenti.
«Con grande piacere», rispose Adeline. «Sarei felicissima di penetrare nelle menti eccentriche di quei giovani brillanti. Sono certa che distruggerò i loro cervelli e falcerò le loro anime con tutti i prodigi del mio eloquio».
Neanche la parodia di Juno in Disaster movie. E sottoscrivo, perché l’intervento al suddetto college, all’autore che lo scrive, deve essere sembrato molto arguto, e invece si risolve d’essere una tirata contro le due entità inventate dall’occidente capitalista: il Dio unico e il Danaro, che, scrive, come nessun’altra entità inventata hanno causato i peggiori danni a questo nostro mondo (ne avrei un altro paio un po’ peggiori, ma non divaghiamo); dunque si passa a una critica alle primavere arabe (nel senso di dissertazione sociopolitica a spiccioloni) e un grande dissenso per internet, Twitter e Facebook, per l’intera industria tecnologica (nonché per le ragazze che tenevano a lavorarci dentro), e per Rhianna e Beyoncè.
Adeline aveva superato la quarantina. Era più o meno famosa. Stava esprimendo una serie di opinioni impopolari. Era in pubblico. Era il 2013. Fu in quel momento che commise l’unico errore imperdonabile dell’inizio del ventunesimo secolo. Non si accorse che qualcuno stava registrando tutto quello che diceva.
Da qui iniziano più o meno trecento pagine di gogna mediatica contro la quale Ella s’erge donchisciottescamente ingenua e salda nei suoi principi.
«Potresti sempre aprirti un account su Twitter e chiedere scusa». «Ma caro», ribatté Adeline, «non posso proprio farlo. Non mi pento affatto di quello che ho detto».
Neanche un pochettino? Un pochetto piccolo piccolo? Piccino picciò?
Approfondimento
Nel 1996 al termine di Fight Club, l’impiegato senza nome si riunisce con la parte più oscura sé, Tyler Durden, figlia della frustrazione e dell’odio per il fordismo culturale e lavorativo al quale è condannato. La sua reazione nei confronti di una società castrante si risolve nel progetto Mayhem, ovvero nella costituzione di una cellula eco-terroristica organizzata per spezzare i pilastri del mondo capitalista-occidentale così come lo conosciamo (gli istituti di credito).
La risposta di Adeline? Lasciamo perdere. Sono stato anche troppo cattivo.
Ma voglio perorare la mia causa. E poi smettere. Ci vogliono spalle enormi per l’avanguardia letteraria. Così come per essere davvero cinici. Altrimenti si rischia di essere smorfiosi e di non attirarsi neppure l’indulgenza della simpatia.
Dear Jarrett, please, take a note: Andrea G. Pinketts – studiare.
Luca Viti [amazon_link asins=’B07H8KBHKQ’ template=’ProductCarousel’ store=’leggacolo-21′ marketplace=’IT’ link_id=’7445998a-013a-11e9-9259-a3c6a5a4ff17′]