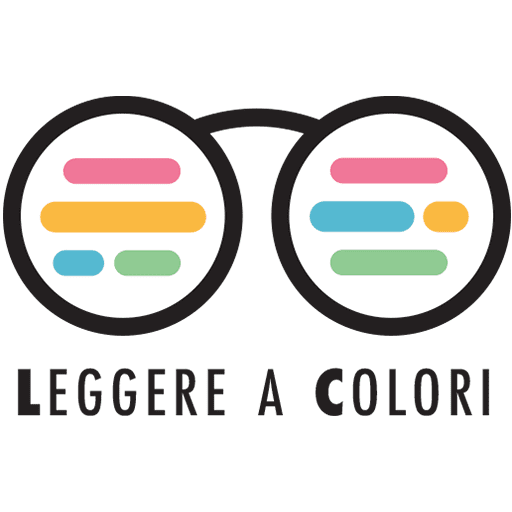Noi siamo ciò che ricordiamo. La cosa peggiore che possa accadere a un essere umano oppure a un intero popolo è la perdita della memoria. Il concetto di memoria è strettamente legato al concetto di identità.Da un punto di vista fisiologico, la nostra mente mentre sta ricordando non preleva il frammento originale in modo automatico ma c’è una complessa elaborazione dell’esperienza. Ecco perché siamo molto differenti dalle macchine e dai computer.
Questo non significa inventarsi i ricordi ma noi dobbiamo fare uno sforzo per ricordare. Nella mia memoria c’è qualcuno che è molto caro per me. Il mio bisnonno materno, Gavino, nato in Sardegna nel 1879 e morto a Napoli nel 1957. Non l’ho conosciuto personalmente ma la mia memoria di lui si è formata nel tempo attraverso i racconti di mio nonno Mario. Mio nonno Mario era quello che si definirebbe l’archetipo dell’uomo sardo. Non molto alto, snello e nervoso. I suoi occhi erano più neri delle bacche di mirto. Lo ricordo in modo vivido mentre nei momenti di pausa con le dita ravvivava i folti capelli grigi, lisciandoli all’indietro con un gesto inimitabile. Quasi a voler tenere raccolti i pensieri. Poi continuava il racconto e la sua voce calda era molto rassicurante per me. Sono stata fortunata ad avere un nonno così. Ero una bambina e spesso mi sedevo vicino a lui ad ascoltare i suoi racconti. Non erano le favole di fate e principesse, tanto care alle bambine, ma storie vere della sua terra nativa, la Sardegna, sulla sua famiglia e, soprattutto, su suo padre, Gavino.
Il mio bisnonno ha vissuto una vita intera dedicate a valori profondi quali l’onestà, la libertà, la cultura con un alto senso della politica e dell’impegno civile. Valori fondamentali, forse comuni per molte persone, ma vissuti con particolare consapevolezza, uno spirito vivo e un carattere combattivo. Alcuni ideali furono coltivati anche se il mio bisnonno pagò un prezzo alto per esso, specie per i suoi ideali socialisti durante il periodo fascista. Egli fu uno strano tipo di emigrante. Quando era in Sardegna, durante la prima metà del XX secolo, egli era un uomo ricco e rispettabile, aveva una bella moglie, alcuni figlioletti e amici di una certa importanza. Aveva una casa grande, era impiegato quale direttore alle poste ed era anche vicesindaco nel suo paese. Inoltre, aveva interessi economici nel sughero ed alcune proprietà terriere.
Ma su tutto dominava la sua passione per la politica e per la letteratura. Fece parte del processo di formazione del partito socialista in Sardegna, sorto proprio a Tempio Pausania, trai lavoratori del sughero. Fu corrispondente per la Nuova Sardegna ed amava organizzare gare poetiche in lingua sarda. Attraverso i racconti del nonno, io ero affascinata della sua passione per la scrittura e per la letteratura. Nel 1904 Gavino incontrò Cesare Pascarella durante il suo secondo viaggio in Sardegna. Pascarella era un poeta romano, famoso per i suoi sonetti in romanesco e carichi di spirito patriottico e popolare. Egli scrisse anche un poema, Villa Glori, sul sacrificio dei fratelli Cairoli, patrioti italiani coinvolti nella Battaglia di Mentana, nel 1867, durante il Risorgimento.Pascarella e il mio bisnonno divennero buoni amici e per rinsaldare il loro sentimento, il poeta romano fece da padrino per il primo figlio di Gavino, Pietro.Il mio nonno ricordava di poesie, racconti e articoli di giornale scritti da Gavino ma si dispiaceva che non fosse rimasto nessun documento. Solo una vecchia foto ingiallita era l’unica testimone di questa storia. Un uomo serio con due grossi baffi neri, occhiali tondi ed uno sguardo intelligente.
Ma perché non c’era più nessuna traccia? Oh, quanto avrei voluto leggere quello che aveva scritto il mio bisnonno!
Mio nonno, a questo punto della storia diventava un po’ triste. Mi rispondeva che finché tutta la famiglia si trovava in Sardegna, ogni cosa era a posto ma una volta giunti a Napoli, dopo i primi anni durante i quali imperversava la Belle Epoque, molte cose erano andate sempre peggio.
Ancora oggi non sono chiare le ragioni esatte che spinsero Gavino e la sua famiglia a trasferirsi a Napoli. Forse Gavino sperava che una città moderna com’era Napoli all’inizio del Novecento avesse potuto offrire maggiori opportunità per i suoi interessi culturali e politici. Napoli in quel tempo era il posto ideale per ispirare intellettuali, scrittori ed artisti da ogni parte del mondo. La città sperimentava un fermento culturale, nonostante le condizioni di povertà di larga parte della popolazione e, grazie all’affermazione dello Stile Liberty l’aspetto della città si rinnovava con sontuosi progetti architettonici. Dopo pochi anni, la Prima Guerra Mondiale spezzò tutti i sogni, poi il periodo fascista e i disastri della Seconda Guerra Mondiale cambiarono completamente la città, sfregiandola dentro e fuori. Napoli fu la città italiana con il maggior numero di bombardamenti. La distruzione era ovunque. Una terribile crisi economica colpì il popolo napoletano e qualcuno approfittò della situazione per diventare ricco in maniera disonesta, come alcuni protagonisti della famosa commedia “Napoli milionaria” scritta da Eduardo De Filippo.
Anche Gavino e la sua famiglia ebbero numerosi problemi derivanti da questi eventi drammatici ma restarono uniti ed integri ad affrontarne le conseguenze. Innanzitutto, la persecuzione politica, dovuta al regime fascista, poi la perdita della casa per un bombardamento e di ogni cosa che conteneva: gioielli, libri, mobili, manoscritti. Così furono costretti a trasferirsi in un piccolo paese, lontano dalla città, fino alla fine della guerra. Per tornare poi a Napoli, tra mille difficoltà del dopoguerra ma con la speranza di un futuro migliore.
Anche nei periodi più difficili, la scrittura dovette essere la silenziosa compagna di un’esistenza semplice, asciutta, senza fronzoli. Mia madre o mio nonno mi raccontavano delle belle riunioni familiari, la domenica pomeriggio, dove tra un dolcino ed un caffè, figli, nipoti ma anche parenti acquisiti e conoscenti si riunivano a casa sua e dove la giovane figlia Miriam leggeva brani di un suo romanzo o di una sua novella. Non solo parenti ma anche amici e conoscenti secondo la nota ospitalità sarda, rivisitata in salsa napoletana. È difficile descriverlo con le parole ma c’è sempre stato come un filo invisibile che mi ha legato a lui. Forse una corrispondenza di amorosi sensi di foscoliana memoria ma anche qualcosa di misterioso e reale al tempo stesso.
Ho sempre nutrito la speranza che qualcosa fosse rimasto dei suoi scritti, magari proprio in Sardegna e ogni tanto provavo a cercare su Internet ma niente: trovavo solo qualcosa del suo omonimo, su poeta christianu. Ma non mi sono mai arresa, ho sempre continuato a cercare.
Finché un giorno, poco più di due anni fa attraverso il motore di ricerca Google, venne fuori l’opera “La Sardegna di Pascarella” con i sonetti di Villa Glori e la traduzione in sardo-anglonese fatta dal mio bisnonno. Provai un’emozione grandissima. Mi misi subito in contatto con il curatore dell’opera e me la feci mandare. Grazie a lui sono riuscita a leggere anche una raccolta di versi sempre in sardo, Boghes de s’anima. Ultimamente, ho trovato anche una novella scritta in italiano, risultata seconda ad un concorso letterario e che tratta dell’ospitalità sarda. Le tre opere sono diverse tra di loro e rivelano una personalità eclettica, riflessiva, a tratti pessimista e malinconica. Non va dimenticata la poesia del primo maggio, Primu de Maju, dove l’ardore degli ideali viene espresso in maniera vibrante contro le ingiustizie subite dalla classe operaia e che fu pubblicata su un giornale socialista dell’epoca. Per me è come se dopo tanti anni, Gavino fosse più vicino e più vivo che mai ed ogni tanto vado a rileggere quei versi e quelle parole che vengono dal passato ma che mi appartengono, quasi fossero impressi nel mio DNA.
Sono e sarò sempre orgogliosa per aver attribuito significato e conservato memoria delle mie origini sarde. Forse è proprio quel 25% di sangue sardo che scorre nelle mie vene a fare talvolta la differenza in termini di carattere e forza di volontà. È qualcosa di forte che ho sempre avvertito. Fin dalla prima volta che ho messo piede in questa splendida terra mi sono sentita a casa mia, anzi in domo mea. E come l’odore della madre è la prima cosa che ricorda ogni figlio, così il richiamo irresistibile dei profumi di questa splendida terra risveglia in me ogni volta pensieri e ricordi atavici che vanno ben oltre i confini del tempo. Ho come l’impressione che con me ogni volta ci sia anche lui, ad attraversare di nuovo quel mare, a ripercorrere quelle stradine tortuose, a sentire quegli aromi freschi e pungenti, risentendo risuonare l’idioma natio.
Anna Cuomo