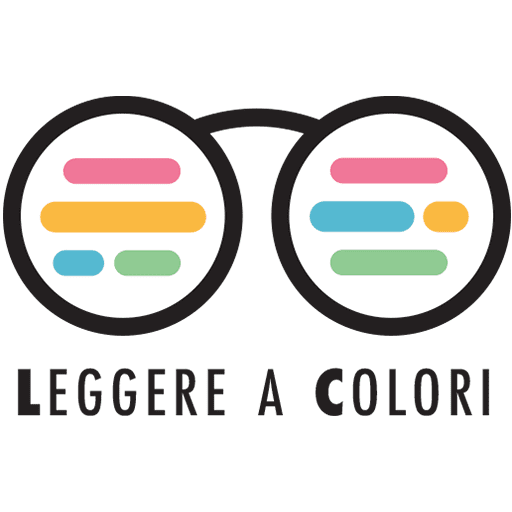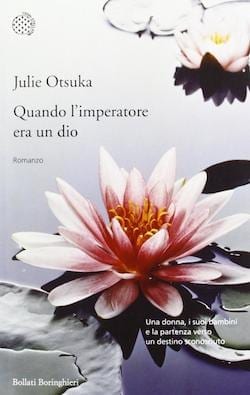 Titolo: Quando l’imperatore era un dio
Titolo: Quando l’imperatore era un dioAutore: Julie Otsuka
Pubblicato da Bollati Boringhieri - 2013
Pagine: 153 - Genere: Romanzo storico
Formato disponibile: Brossura
Collana: Varianti
📗 Acquista scontato su ibs.it
📙 Amazon (spedizione gratuita)
✪ Le recensioni dei lettori su Goodreads
Lo scoppio della guerra e la decisione di considerare i cittadini americani di origine giapponese come potenziali nemici. Protagonista di questo romanzo è una famiglia composta da quattro persone: padre, madre, figlio e figlia. Il padre prelevato durante la notte dall’FBI, la madre e i figli deportati in un campo di lavoro nel deserto dello Utah. La sofferenza e la miseria si intrecciano con le illusioni e la speranza di poter tornare alla vita di sempre.

All’indomani dell’attacco di Pearl Harbour i cittadini americani di origine giapponese si preparano all’esodo mettendo al riparo beni materiali, a cui sono legati anche affettivamente (il servizio di piatti e l’argenteria), e sperando di ritrovare intatta la casa e l’intero mobilio. L’FBI si mette alla ricerca di uomini che, sospettati di tradimento nei confronti degli americani, vengono portati via di notte per essere interrogati e successivamente incarcerati. Le donne e i bambini vengono caricati sui treni e portati nei campi di lavoro.
“Era il 1942. Nello Utah. Sul finire dell’estate. Una città di baracche rivestite di carta catramata dentro una recinzione di filo spinato, su un polveroso altopiano alcalino nel deserto. Soffiava un vento caldo e secco e pioveva di rado, e il bambino lo vedeva ovunque guardasse: papà, babbo, padre, Oto-san. Perché era vero, si somigliavano tutti. Capelli neri. Occhi a mandorla. Zigomi alti. Occhiali spessi. Labbra sottili. Denti guasti. Inconoscibili. Imperscrutabili. Eccolo là, era lui. Il piccolo uomo giallo” (p. 31).
Ma le avvisaglie della diffidenza nei confronti dei cittadini di origine giapponese si manifestano nel 1941. Niente lavoro, solo insulti ed emarginazione sociale. “Alcuni tornarono indossando le stesse scarpe con cui erano partiti, e giurarono che non ci sarebbero più andati. Dissero che gli avevano sparato. Gli avevano sputato addosso. Gli avevano proibito l’ingresso al diner. Al cinema. Alla merceria. Dissero che, dovunque andassero, i cartelli nelle vetrine dicevano tutti la stessa cosa: VIETATO L’INGRESSO AI GIAPPONESI” (p. 40).
I protagonisti di questo romanzo restano tre anni e cinque mesi lontani da casa, soffrendo il freddo e il caldo del deserto pur avendo la possibilità di utilizzare acqua e di ricevere il cibo, una branda e una stufa. Nessuno di loro
“avrebbe mai dimenticato la polvere. Morbida, bianca e gessosa come talco. Ma l’alcalinità irritava la pelle. Faceva sanguinare il naso. Faceva bruciare gli occhi. Toglieva la voce. La polvere entrava nelle scarpe. Nei capelli. Nei calzoni. Nella bocca. Nel letto. Nei sogni” (p. 39).
La speranza e il desiderio di ricongiungersi al proprio capo famiglia, dal quale continuano a ricevere lettere rassicuranti, nonostante i segni evidenti della censura (frasi cancellate), aiutano a sopportare meglio gli stenti e la lontananza. Poi, finalmente, tutto finisce e si torna a casa.
“Non è cambiato niente, ci dicemmo. La guerra era stata un’interruzione, niente di più. Avremmo ripreso la nostra vita nel punto in cui l’avevamo sospesa e saremmo andati avanti. Saremmo tornati a scuola. Avremmo studiato tanto, tutti i giorni, per recuperare il tempo perduto. Avremmo ritrovato i nostri vecchi compagni” (p. 65).
Dopo oltre quattro anni di prigionia il padre ritrova la sua famiglia. Nonostante i suoi 56 anni è già vecchio, gracile e debole nel fisico. Insomma, un’altra persona.
“Nostro padre, il padre che ricordavamo, e che avevamo sognato quasi ogni notte per tutti gli anni della guerra, era bello e forte. Si muoveva rapido, sicuro, a testa alta. Gli piaceva disegnare per noi. Gli piaceva cantare per noi. Gli piaceva ridere. L’uomo che era tornato in treno sembrava molto più vecchio dei suoi cinquantasei anni. Portava una dentiera bianchissima e aveva perso tutti i capelli. Ogni volta che lo abbracciavamo sentivamo le costole sotto la stoffa della camicia. Non disegnava per noi, non ci cantava canzoni con la sua voce incerta e stonata. Non ci leggeva le storie” (p. 77).
Quando l’imperatore era un dio è il racconto corale di un’intera famiglia (padre, madre, figlio e figlia) che rimane anonima fino alla fine della narrazione. Una scelta che, oltre ad essere un’esigenza stilistica, è certamente una presa di posizione dell’autrice, Julie Otsuka: le voci narranti sono emblematiche e rappresentative di tutte quelle voci che vissero il periodo di guerra e di persecuzione nel pieno silenzio, senza nome e senza volto. L’autrice mette in scena la mostruosità della guerra con obiettività, usando un linguaggio semplice, diretto e composto che contribuisce a trasformare questo romanzo in una testimonianza di una vicenda storica poco conosciuta.
Pasquale Braschi