Benvenuti a una nuova puntata del nostro corso di scrittura creativa online! La questione sulla scelta del punto di vista è una delle più annose dell’intero panorama letterario, ed è anche una delle più sottovalutate dai neofiti. Ogni epoca storica ha avuto delle precise tendenze in merito che spesso ci rivelano moltissimo non solo sul tipo di storia raccontata, quanto piuttosto sugli usi e credenze della società che aveva prodotto quello scritto. In quest’articolo ci proponiamo di introdurre i principali punti di vista che vengono utilizzati nella scrittura creativa ma soprattutto di discutere le problematiche che si spalancano alla scelta del punto di vista, problematiche che, se sottovalutate, conducono inevitabilmente a una storia mal scritta e, quindi, di scarso successo.
È necessario innanzitutto precisare che il punto di vista su una storia non coincide col punto di vista dell’autore di quella storia, almeno non necessariamente. Questa affermazione sembra una banalità (e forse lo è per certi aspetti), ma troppe volte si fa confusione fra le due cose. Lo scrittore attento demarca in maniera netta quello che è il proprio punto di vista di autore da quello che è il punto di vista dei suoi personaggi. A maggior ragione se uno di questi personaggi è anche il narratore della storia. Quanto più è marcato questo solco, tanto più l’autore ha l’agio di poter prendere le distanze dalle vicende raccontate. Come esempio si pensi ai “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. Si tratta di un libro che tutti conosciamo per averlo diffusamente studiato a scuola, ed effettivamente si tratta di un romanzo classico ed esemplare sotto molteplici punti di vista, anche se qualche volta ci è venuto a noia proprio a causa del fatto che abbiamo dovuto studiarlo in un’età in cui difficilmente avremmo potuto apprezzarlo. Spesso si dice che il romanzo manzoniano sia narrato con una “terza persona onnisciente” (e vedremo, nel seguito, di dare una definizione di questo particolare punto di vista), tuttavia questa onniscenza è demarcata con molta precisione. Il Manzoni ricorre infatti all’artificio del manoscritto: il romanzo cioè non sarebbe un’invenzione ma una cronaca. Una cronaca scritta in un linguaggio arcaico, rinvenuta accidentalmente dall’autore il quale ne diventa il curatore, il traduttore. Il vero autore del manoscritto manzoniano resta anonimo. Perché questa scelta? Il Manzoni, nell’introduzione al libro, dopo aver citato quello che sarebbe l’incipit del manoscritto, afferma di avere avuto la tentazione di gettarlo via, se non che:
“Nell’atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che una storia così bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta; perché, in quanto storia, può essere che al lettore ne paia altrimenti, ma a me era parsa bella, come dico; molto bella. Perché non si potrebbe, pensai, prender la serie de’ fatti da questo manoscritto, e rifarne la dicitura? Non essendosi presentato alcuna obiezion ragionevole, il partito fu subito abbracciato. Ed ecco l’origine del presente libro, esposta con un’ingenuità pari all’importanza del libro medesimo. “
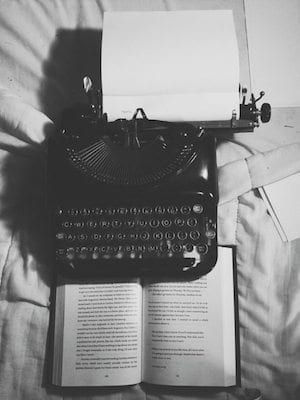 Manzoni gioca col lettore e, al contempo, ammicca, allude, insinua. Il manoscritto è ampolloso, afferma, scritto con stile scorretto, addirittura infarcito di “idiotismi”, purtuttavia egli, mosso dalla bellezza dei concetti trattati, si offre di correggerlo, trasporlo in uno stile più posato e lineare, si pone in posizione subalterna rispetto all’autore anonimo seicentista. Ne “I Promessi Sposi” abbiamo dunque due autori: il fittizio seicentista e quello reale che è il Manzoni stesso. Così facendo l’autore reale ottiene una serie di effetti intriganti per il lettore: forisce un retroscena di autenticità (seppur simulata) al romanzo storico che, in quanto tale, diviene più realistico, crea un’aspettativa nel lettore sul testo stesso e, contemporaneamente si tira fuori, fa il modesto, se opinioni sono espresse nel manoscritto, queste non sono già dell’autore-Manzoni, ma dell’anonimo che è figlio del suo tempo. E tuttavia, attraverso le vicende del Seicento, Manzoni elabora il tema reale del libro: il potere che diventa sopraffazione e violenza, la dominazione dello straniero, il significato del pentimento e la presenza di una forza divina che regola i destini degli uomini. E così via. Ecco che quella scelta comincia ad assumere un significato ben preciso: narrare la storia di un altro, il quale si pone a sua volta come occhio onnisciente sull’intera vicenda e di questa vicenda offre una lettura particolare che è unica, definita. La visione è onnisciente perché trapassa tutti i muri e tutti i pensieri dei protagonisti, nella misura in cui l’artificio del manoscritto glie ne detta i confini. La terza persona onnisciente del Manzoni per questo motivo è la più adatta a raccontare quel tipo di storia.
Manzoni gioca col lettore e, al contempo, ammicca, allude, insinua. Il manoscritto è ampolloso, afferma, scritto con stile scorretto, addirittura infarcito di “idiotismi”, purtuttavia egli, mosso dalla bellezza dei concetti trattati, si offre di correggerlo, trasporlo in uno stile più posato e lineare, si pone in posizione subalterna rispetto all’autore anonimo seicentista. Ne “I Promessi Sposi” abbiamo dunque due autori: il fittizio seicentista e quello reale che è il Manzoni stesso. Così facendo l’autore reale ottiene una serie di effetti intriganti per il lettore: forisce un retroscena di autenticità (seppur simulata) al romanzo storico che, in quanto tale, diviene più realistico, crea un’aspettativa nel lettore sul testo stesso e, contemporaneamente si tira fuori, fa il modesto, se opinioni sono espresse nel manoscritto, queste non sono già dell’autore-Manzoni, ma dell’anonimo che è figlio del suo tempo. E tuttavia, attraverso le vicende del Seicento, Manzoni elabora il tema reale del libro: il potere che diventa sopraffazione e violenza, la dominazione dello straniero, il significato del pentimento e la presenza di una forza divina che regola i destini degli uomini. E così via. Ecco che quella scelta comincia ad assumere un significato ben preciso: narrare la storia di un altro, il quale si pone a sua volta come occhio onnisciente sull’intera vicenda e di questa vicenda offre una lettura particolare che è unica, definita. La visione è onnisciente perché trapassa tutti i muri e tutti i pensieri dei protagonisti, nella misura in cui l’artificio del manoscritto glie ne detta i confini. La terza persona onnisciente del Manzoni per questo motivo è la più adatta a raccontare quel tipo di storia.
Facciamo un altro esempio considerando “Il nome della rosa” di Umberto Eco. Similmente al Manzoni, anche Eco ricorre all’artificio del manoscritto ritrovato. Nella introduzione del libro infatti si legge:
“Il 16 agosto 1968 mi fu messo tra le mani un libro dovuto alla penna di tale abate Vallet, “Le manuscript de Dom Adson de Melk, traduit en français d’après l’‚èdition de Dom J. Mabillon” (Aux Presses de l’Abbaye de la Source, Paris, 1842). Il libro, corredato da indicazioni storiche invero assai povere, asseriva di riprodurre fedelmente un manoscritto del Quattordicesimo secolo, a sua volta trovato nel monastero di Melk dal grande erudito secentesco, a cui tanto si deve per la storia dell’ordine benedettino.”
Eco afferma che questo manoscritto gli fu “messo tra le mani”, il che sottintende una dose di casualità, e continua tracciando una serie di riferimenti bibliografici (rivelatisi poi anche fallaci ed imprecisi) e citazioni di altri autori non suffragate da prove. E così Eco, l’autore reale, non potendo suffragare con prove storiche l’autenticità del manoscritto, afferma di averlo curato e tradotto per puro amore dei libri poiché è questo di cui tratta il manoscritto stesso:
“E così ora mi sento libero di raccontare, per semplice gusto fabulatorio, la storia di Adso da Melk, e provo conforto e consolazione nel ritrovarla così incommensurabilmente lontana nel tempo (ora che la veglia della ragione ha fugato tutti i mostri che il suo sonno aveva generato), così gloriosamente priva di rapporto coi tempi nostri, intemporalmente estranea alle nostre speranze e alle nostre sicurezze. Perché‚ essa è storia di libri, non di miserie quotidiane, e la sua lettura può inclinarci a recitare, col grande imitatore da Kempis: “In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro” (Ho cercato pace ovunque, senza trovarla mai tranne che in un angolo con un libro)”
Ma cosa sta facendo Eco qui? Sta introducendo i veri temi del romanzo: afferma che trattasi di storia lontana nel tempo e dalla nostra sensibilità. Ma ammicca affermando che l’uomo di oggi grazie alla ragione ha fugato tutti i mostri che il sonno della ragione stessa aveva generato ed è come se domandasse al lettore: “sicuri che è davvero così?” Infatti scopriremo che le vicende narrate da Adso da Melk, sebbene lontane nel tempo, parlano di problemi che attanagliano l’uomo da sempre e lo assedieranno finché esisterà. Non è una mera storia di libri (le cui fonti sono peraltro spesso contraddittorie quando non addirittura inventate, così come ha affermato poco prima), ma una storia di amore per la conoscenza, è la lotta della ragione con la superstizione. Per di più Eco introduce una ulteriore figura intermedia, quella di certo abate Vallet, che avrebbe a sua volta trascritto (o falsificato?) la storia di Adso. Peché ciò? Ma per poter raccontare “per semplice gusto fabulatorio” la vicenda. Senza altre pretese che non siano l’intrattenimento. Non siamo più nell’Ottocento, il Manzoni è lontano ormai. Il romanzo è narrato in prima persona distaccata. L’io narrante è Adso da Melk, l’autore del manoscritto originario che si rivela un mistero. L’io narrante in prima persona aiuta questo tipo di trama: avrà l’autore svelato il mistero? leggendo troveremo le risposte che cerchiamo? È sopravvissuto il protagonista? Sì perché Adso da Melk è l’io narrante, è colui che ci presta il punto di vista sulla storia, ma il protagonista è un altro. Si chiama Guglielmo da Baskerville e sono le sue vicende che andiamo a scoprire (su questo punto torneremo in seguito).
Forse ci siamo dilungati un po’ troppo con questi esempi, tuttavia servirà a far comprendere l’importanza e la stretta relazione esistente fra elementi di una storia che abbiamo già introdotto in articoli precedenti e cioè: tema, trama, personaggio e l’altra relazione sussistente fra questi e la scelta del punto di vista. Deve esser chiaro che questa scelta introduce un vero e proprio contratto fra l’autore e il lettore, un contratto che non va mai disatteso, pena la perdita del lettore stesso. I termini del contratto sono quelli evidenziati negli esempi: che tipo di storia dovrà aspettarsi il lettore? Attraverso quali occhi glie la faremo vivere? Abbiamo ben chiaro in mente che tipo di storia stiamo raccontando? A chi appartiene? Quali regole dovremo rigorosamente rispettare come autori per non infrangere questo contratto? Vediamole nel dettaglio per ciascuna tipologia principale di punto di vista.
Prima persona.
I racconti scritti in prima persona sono narrati da un personaggio. Questi può essere il protagonista o meno, in ogni caso scegliendo la prima persona come punto di vista si affida interamente all’io narrante. Ciò significa che non solo la coerenza della storia, ma anche lo stile e le idee dovranno essere conformi al protagonista scelto. Se scegliamo di far raccontare una storia pulp da un barbone, non possiamo utilizzare un linguaggio aulico bensì dovremo usare uno slang da strada, a me no di non doverlo adeguatamente giustificare (il nostro barbone in passato era un nobile poi decaduto?). Se il narratore ha un’intelligenza media, non potremo pretendere da lui deduzioni degne di uno Sherlock Holmes. Perché cio? Perché altrimenti perdiamo la stima del lettore il quale cessa di sospendere la sua incredulità rendendo vani i nostri sforzi di creare un climax ed una trama avvincente. La maggiore difficoltà di questo punto di vista è che l’autore rimane bloccato sull’io-narrante, fermo alla sua visione, alle sue convinzioni. Per questo motivo, in molti casi, il narratore preferisce affidarsi a forme alternative di prima persona. Cambiando ad esempio spesso l’io-narrante affindandosi ad artifici di varia natura. Il romanzo epistolare, ad esempio, è una forma di narrativa, che andava molto di moda nell’Ottocento, in cui si introducono più io-narranti usando la forma di lettere. Questa forma si ritrova anche nella letteratura contemporanea.
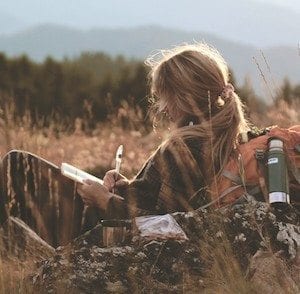 Ad esempio, ne “Il Pendolo di Foucault” di Umberto Eco, si escogita l’artificio di intervallare il racconto di Casaubon, uno dei personaggi, con aneddoti e fatti vissuti dal protagonista che è Jacopo Belbo attraverso il ritrovamento da parte del primo di files nella memoria di un personal computer. Così facendo si ha la possibilità di introdurre viste con angolazioni diverse sulla vicenda, dettagli e considerazioni interpretative, che l’io-narrante principale non può conoscere. Un altro stratagemma spesso usato consiste nell’io-narrante distaccato o periferico. Si fa in modo cioè che non sia il protagonista a narrare, bensì un altro personaggio minore. Perché si opera questa scelta? In genere l’autore si affida a questa modalità di narrazione quando il protagonista non ha piena consapevolezza delle proprie azioni, ovvero quando il protagonista stesso è un “personaggio completo”, cioè la sua epifania già è avvenuta in un tempo antecedente rispetto alla narrazione, egli è già cambiato e non cambierà più durante la vicenda. Tuttavia le sue azioni produrranno un cambiamento nel personaggio secondario scelto come io-narrante. Questo perché se l’io-narrante si trasforma ed evolve durante la narrazione, tale trasformazione offre interessantissimi spunti narrativi: nuove visioni della realtà si schiudono davant al lettore. Come esempio ricordiamo l’Ismaele del “Moby Dick” di Melville che racconta le vicende che hanno come protagonista Achab il quale è già un personaggio completo poiché le vicende che lo hanno reso ciò che è al tempo della narrazione sono già avvenute in un un tempo antecedente a quello in cui Ismaele scrive la sua storia.
Ad esempio, ne “Il Pendolo di Foucault” di Umberto Eco, si escogita l’artificio di intervallare il racconto di Casaubon, uno dei personaggi, con aneddoti e fatti vissuti dal protagonista che è Jacopo Belbo attraverso il ritrovamento da parte del primo di files nella memoria di un personal computer. Così facendo si ha la possibilità di introdurre viste con angolazioni diverse sulla vicenda, dettagli e considerazioni interpretative, che l’io-narrante principale non può conoscere. Un altro stratagemma spesso usato consiste nell’io-narrante distaccato o periferico. Si fa in modo cioè che non sia il protagonista a narrare, bensì un altro personaggio minore. Perché si opera questa scelta? In genere l’autore si affida a questa modalità di narrazione quando il protagonista non ha piena consapevolezza delle proprie azioni, ovvero quando il protagonista stesso è un “personaggio completo”, cioè la sua epifania già è avvenuta in un tempo antecedente rispetto alla narrazione, egli è già cambiato e non cambierà più durante la vicenda. Tuttavia le sue azioni produrranno un cambiamento nel personaggio secondario scelto come io-narrante. Questo perché se l’io-narrante si trasforma ed evolve durante la narrazione, tale trasformazione offre interessantissimi spunti narrativi: nuove visioni della realtà si schiudono davant al lettore. Come esempio ricordiamo l’Ismaele del “Moby Dick” di Melville che racconta le vicende che hanno come protagonista Achab il quale è già un personaggio completo poiché le vicende che lo hanno reso ciò che è al tempo della narrazione sono già avvenute in un un tempo antecedente a quello in cui Ismaele scrive la sua storia.
Questo artificio dà al narratore anche un altro agio: quello cioè di poter parlare del protagonista senza avera accesso ai suoi pensieri, il che conferisce un ulteriore elemento di mistero poiché consente di sviluppare il lato in ombra del protagonista stesso. Un tipo di narrazione in prima persona che va molto di moda ai giorni nostri è quella in cui il narratore non è in sé o non è coerente, è cioè inaffidabile. L’io-narrante ha una visione distorta della storia che sta narrando, non conosce alcuni dettagli fondamentali e li immagina, o semplicemente mente. Nel romanzo “Fight Club” dello scrittore statunitense Chuck Palahniuk il protagonista resta addirittura anonimo durante tutto lo svolgimento della storia ma il suo dualismo folle, il suo alter ego Tyler Durden, sono parte integrante della trama. Lo sdoppiamento schizofrenico del narratore è alla base dell’intreccio che non sarebbe altrettanto efficace se fosse raccontato da un narratore in sé e coerente dall’inizio alla fine. Questo punto di vista è molto usato dagli autori contemporanei in quanto consente di mettere in luce un certo relativismo delle vicende narrate in cui non esiste un’unica realtà ed un’unica interpretazione, ma possono essercene molteplici e nessuna di queste è da privilegiare rispetto alle altre.
Terza persona.
Nel punto di vista in terza persona la voce narrante non è in genere un personaggio della storia, bensì una voce creata ad arte dall’autore con il solo scopo di narrare la storia nella maniera più efficace. Nel caso più generico, la terza persona immersa, il punto di vista coincide con quello dell’io narrante in prima persona. Tuttavia il tempo verbale è in terza persona il che consente all’autore di poter utilizzare un linguaggio più completo anche se ha accesso ai soli pensieri del personaggio narrante. Inoltre questo tipo di narrazione offre ulteriori vantaggi: è impossibile infatti dedurre alcunché sull’esito della storia e sul destino del protagonista narrante, cosa difficilissima da attuare quando si narra in prima persona giacché – in questo caso – è implicito (nell’ambito della sospensione dell’incredulità, s’intende) che il personaggio narrante è sopravvissuto alle vicende per poterle raccontare. Con la terza persona questo non si può dire ed è un elemento di notevole vantaggio per creare storie dal finale imprevedibile in cui fino alla fine il lettore ignora la sorte del protagonista. Ne “Il Signore degli Anelli” di J.R.R. Tolkien, la storia è raccontata attraverso la penna di Frodo Baggins che è anche il protagonista.
 Tuttavia Frodo decide di scrivere il libro in terza persona e, sebbene sia chiaro che gli occhi del narratore siano i suoi, non è mai da escludere che egli sia effettivamente sopravvissuto fino alla fine per raccontare tutto giacché il libro potrebbe essere stato completato da un’altra mano, sconosciuta al lettore (come pure accade nell’appendice sugli “Annali di re e governatori”). Questo dettaglio è indispensabile per creare la sospensione dell’incredulità senza la quale è difficilissimo se non impossibile mantenere la tensione fino alla fine. Questo tipo di terza persona non è l’unico possibile. Infatti, nella storia della letteratura, si è assistito ad altri tipi di terza persona come quella multipla e quella onnisciente. Nel primo caso (tipico dei lunghi romanzi in quanto richiede una caratterizzazione assai spinta dei personaggi), l’autore propone dei punti di vista alternati. In altri termini, la narrazione è sempre in terza persona tuttavia il punto di vista muta, saltando di personaggio in personaggio. Normalmente esiste sempre un punto di vista prevalente ma è sempre possibile cambiare all’occorrenza il punto di vista per offrire una diversa vista su alcuni eventi particolari della narrazione. In questo caso si parla di terza persona multipla e, per l’autore, si tratta di un lavoro per niente semplice. I personaggi attraverso cui si narra la storia, infatti, devono possedere visioni marcatamente diverse non solo della storia, ma anche dei valori, delle credenze e della vita in genere. Per di più all’autore è richiesto uno sforzo extra per tenere viva l’attenzione sul personaggio principale giacché un abuso dei punti di vista multipli può facilmante sviare l’attenzione del lettore.
Tuttavia Frodo decide di scrivere il libro in terza persona e, sebbene sia chiaro che gli occhi del narratore siano i suoi, non è mai da escludere che egli sia effettivamente sopravvissuto fino alla fine per raccontare tutto giacché il libro potrebbe essere stato completato da un’altra mano, sconosciuta al lettore (come pure accade nell’appendice sugli “Annali di re e governatori”). Questo dettaglio è indispensabile per creare la sospensione dell’incredulità senza la quale è difficilissimo se non impossibile mantenere la tensione fino alla fine. Questo tipo di terza persona non è l’unico possibile. Infatti, nella storia della letteratura, si è assistito ad altri tipi di terza persona come quella multipla e quella onnisciente. Nel primo caso (tipico dei lunghi romanzi in quanto richiede una caratterizzazione assai spinta dei personaggi), l’autore propone dei punti di vista alternati. In altri termini, la narrazione è sempre in terza persona tuttavia il punto di vista muta, saltando di personaggio in personaggio. Normalmente esiste sempre un punto di vista prevalente ma è sempre possibile cambiare all’occorrenza il punto di vista per offrire una diversa vista su alcuni eventi particolari della narrazione. In questo caso si parla di terza persona multipla e, per l’autore, si tratta di un lavoro per niente semplice. I personaggi attraverso cui si narra la storia, infatti, devono possedere visioni marcatamente diverse non solo della storia, ma anche dei valori, delle credenze e della vita in genere. Per di più all’autore è richiesto uno sforzo extra per tenere viva l’attenzione sul personaggio principale giacché un abuso dei punti di vista multipli può facilmante sviare l’attenzione del lettore.
Questo, come si è visto nell’articolo precedente sui personaggi, è deleterio per molti motivi ai fini della buona riuscita del testo. Un’altra forma (peraltro assai nota) di terza persona è quella onnisciente. In questo caso, il narratore ha uno sguardo illimitato sulla narrazione, uno sguardo “divino” che travalica lo spazio e il tempo. Il narratore può accedere ai pensieri di tutti i personaggi, conosce passato e futuro e pertanto decide di rivelare i dettagli al lettore nell’ordine che ritiene più opportuno. Si comprende che questo punto di vista gode di innumerevoli vantaggi poiché unisce i vantaggi della prima persona a quelli della terza. La narrazione non è in alcun modo limitata dai personaggi il che si traduce nella rimozione di tutti i vincoli fra autore, narratore e storia. Il punto di vista in terza persona onnisciente è molto antico: è il punto di vista delle grandi storie dell’antichità, dei poemi omerici, della mitologia. Il narratore onnisciente, ad esempio, può creare la tensione nel lettore rivelando particolari che sono sconosciuti ai personaggi, oppure giustificare un comportamento apparentemente bizzarro di uno di essi, giacché ha accesso ai pensieri di tutti. Tuttavia l’utilizzo della terza persona onnisciente, è inevitabile, rivela la presenza di un narratore onnipresente. Questo è deleterio nell’ottica della sospensione dell’incredulità e, inoltre, “spersonalizza” la storia, distaccandola un po’ troppo dai personaggi. I lettori che amano le storie dei personaggi e con i personaggi finiscono col non amare troppo la terza persona onnisciente. Tuttavia, se però pensiamo a “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni, ci accorgiamo che la terza persona onnisciente non impedisce affatto la creazione e la caratterizzazione di personaggi memorabili. Spesso si tratta di gusti e di epoche: i lettori odierni infatti sembrano preferire le storie dei personaggi ma generalizzare è sempre sbagliato. Come sempre, la scelta del punto di vista più adatto non può prescindere dal tipo di storia che si intende raccontare. Questo, cari aspiranti scrittori, nessuno può insegnarvelo eccetto l’esperienza. Per oggi è tutto… Alla prossima puntata del nostro corso di scrittura creativa!
