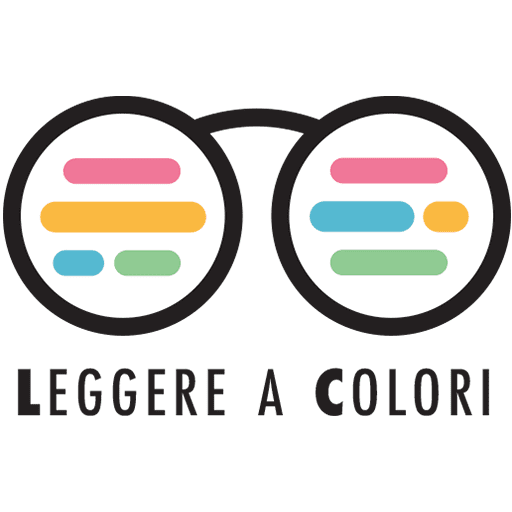Quante volte ti sei sentito contro questa società?
Ti sei sentito diverso, o perché poco compreso o perché troppo compreso (o dovrei dire “compresso”), divenendo così parte della scena e rendendoti conto di chi c’è dietro di essa.
Questa società somiglia ad un teatro di ombre.
C’è chi si limita a fidarsi di quel che l’occhio mostra e chi vuol guardare dietro le tende e vedere la realtà della rappresentazione.
– Cosa guardi?
– Il cielo
– Ma se stai guardando il soffitto! Dove lo vedi il cielo?
– Perché fai domande di cui conosci già la risposta? E poi io il cielo lo vedo …
– Sei rinchiusa in questa casa da un anno, secondo me non lo ricordi nemmeno il colore del cielo!
– E’ azzurro
– Sì, diciamo di sì-
Chiuse gli occhi e riprese: – E’ azzurro. Una grande pennellata di color azzurro fatta su una tela liscia, perfetta, sulla quale si posano dolcemente sfumature biancastre. E’ un qualcosa di estremamente allegro e armonioso. Poi ci sono volte in cui il cielo piange, forse per rabbia, forse per tristezza, sì, per tristezza. Piange per tristezza e dona, con le sue lacrime, tanti sorrisi alla gente.
La pioggia.
Il cielo non può mai far male, vedi? Anche quando diventa nero o grigio, e fa tanta paura esso dona sorrisi alle persone, a quelle sole, a quelle in compagnia e a quelle che non possono sentirne la freschezza sul corpo, l’odore sul viso, la lucentezza e la purezza che accarezza gli occhi ma possono sentire con le loro orecchie con quanta vita batte sui tetti e sulle diverse superfici. Vivo della melodia che il cielo mi dona da un anno. Mi addormento con essa ogni qualvolta piove.
– Lo hai mai visto un arcobaleno?
– No. Là dove sono nata non pioveva quasi mai, ma papà mi parlava spesso degli arcobaleni.
– E come mai?
– Mio padre voleva un figlio, ebbe una figlia.
Quando nacqui io un grande arcobaleno incorniciò il cielo, mio padre mi diceva sempre “Un giorno, quando l’arcobaleno spunterà fuori, come il giorno in cui sei nata, tu mi darai la mano e … aspetta, me la darai vero?”
“Sì” gli rispondevo io sorridendo. Non mi piaceva contraddirlo, soffriva già tanto per l’assenza di mia madre causata dal suo lavoro.
Dopo avergli dato la mano mi diceva -“Attraverseremo quel cielo insieme, poi salteremo l’arcobaleno e tu diverrai un bellissimo fanciullo.”
Già, mio padre aveva sempre desiderato un bambino, un bambino che in un futuro sarebbe diventato un grande uomo.
Qualcuno batteva violentemente un pugno sulla porta.
– Azz… cercano di entrare per l’ennesima volta, esci fuori ed inventati qualche scusa.
– Ma.. l’ospedale dove ti porteranno ti farà solo bene, loro non vogliono il tuo male.
– Perché continui a stare ancora qui con me? Vattene da loro, non ho bisogno della tua pietà. Me la so cavare da sola. Vattene!
– Io non ti lascio da sola, ma devi capire che voglio soltanto il tuo bene.
– I miei genitori non sono riusciti a volere il mio bene ed io dovrei pretendere che uno sconosciuto come te possa volerlo?
– Non sono uno sconosciuto cara e lo sai …
Non si sentirono più rumori, se ne erano andati ancora una volta.. Ma quanto sarebbe durata quella situazione?
Chiuse gli occhi e disse sottovoce:
– Non ce la faccio più a stare qui. Voglio uscire.
– Usciremo presto, molto presto
– Quanto presto?
– Domani.
– Ok, buona notte.
– Ma sono solo le 16.
– Io non la vedo la luna, la immagino.. Non vedo le stelle e il buio, così li immagino. Per me è notte, perché ora voglio la notte.
– Buona notte.
Questa sottospecie di testo non è frutto della mia immaginazione (ammetto che qualcosa di mio c’è, dato che non ero ancora nata quando tutto accadde) …
La ragazza che voleva attraversare l’arcobaleno per suo padre, esiste.
Il giorno dopo uscì di casa, per andare all’ospedale e trovò ad aspettarla un arcobaleno. Affrontò la sua “malattia” e continuò a vivere.. da vera donna.
Perché attraversò quell’arcobaleno e capì che compiendo quel gesto non sarebbe diventata un fanciullo, ma una donna, la donna di cui suo padre sarebbe stato orgoglioso.
La sua malattia era causata dalla perdita di due figli. La lasciarono a pochi mesi di vita, appena nati. Lei aveva solo 18 anni e non riuscì a sopportare il grande dolore. I comportamenti che i suoi suoceri avevano adottato con lei erano di una violenza psicologica assurda. La incolpavano della morte dei suoi figli.
Si rinchiuse in casa. Suo marito le diceva di uscire, di farsi forza, ma lei non riusciva a vedere in faccia la gente, si sentiva debole e priva di qualcosa che apparteneva alla sua vita.
Restò in casa, chiusa.
Questa era la sua malattia, che affrontò andando in quell’ospedale.
Ho mai detto dove si trovava quell’ospedale? Chi erano i suoi medici?
No, suppongo di No.
Quell’ospedale era casa sua, i suoi medici erano la sua famiglia e il loro amore, che spesso, per opinione pubblica, era stato coperto da un lenzuolo di ipocrisia.
Emel