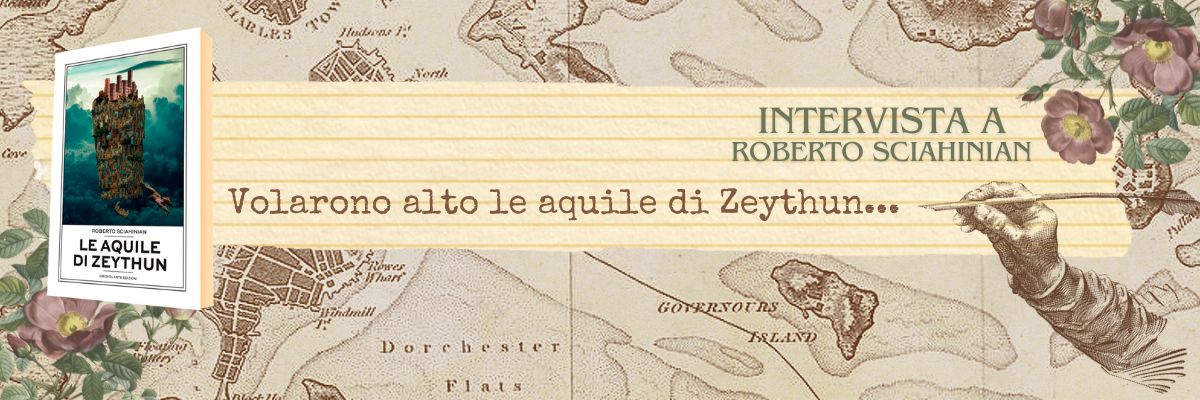Parlare di guerra e di genocidio in questo momento storico potrebbe sembrare abbastanza inutile. Alcune persone sono spaventate dai grandi conflitti che stanno cambiando gli equilibri delle Potenze, altre ne sono vittime dirette a causa del luogo dove vivono o perché rivendicano la propria terra o il diritto a professare la propria religione. Ogni anno sulla terra si combattono migliaia di conflitti per ragioni simili, in terre lontane dalla nostra e in qualche modo hanno sempre un impatto, piccolo o più decisivo, su tutta la popolazione mondiale, anche se non ce ne accorgiamo.
Riflettendo però sono giunto alla conclusione che parlare di questi argomenti, guerra e genocidio, mentre grandi ferite sono aperte può essere un’opportunità di sensibilizzazione per tutti, adesso che forse prestiamo maggiore attenzione, a maggior ragione per le nuove generazioni. È importante riconoscere i genocidi e apprendere dalla storia per prevenire futuri atti simili e per promuovere la pace, la giustizia e i diritti umani. La memoria dei genocidi è fondamentale per la prevenzione e la promozione dei valori umanitari.
Conoscete la storia del genocidio armeno? Il Genocidio Armeno è stata l’eliminazione sistematica e deliberata della popolazione armena da parte dell’Impero Ottomano durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. Il termine “genocidio” in realtà ancora non esisteva dato che fu coniato dall’avvocato polacco Raphael Lemkin nel 1944 e successivamente riconosciuto nel diritto internazionale attraverso la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio delle Nazioni Unite del 1948. Quello armeno è considerato uno dei primi genocidi moderni, se non il primo, una grave atrocità del XX secolo. Il genocidio si è verificato tra il 1915 e il 1923, causando la morte di circa 1,5 milioni di armeni. Roberto Sciahinian ha compiuto un grande lavoro di ricostruzione storica che ha riversato nel suo romanzo attraverso fatti, luoghi, costumi, date, descrivendo a tutto tondo l’identità del popolo armeno, elementi del periodo pre-sterminio. Sciahinian fotografa il coraggio, il forte orgoglio e il senso di appartenenza degli armeni alla comunità e alla propria terra. Il soggetto che inquadra per condividere con noi questa storia è Zeythun, città simbolo della resistenza, che ha tramandato nella storia le gesta di uomini vessati ma forti, un pugno di uomini che non piegano la testa né a un forte impero forte né a un popolo assai più numeroso.
In questa intervista faremo due chiacchiere con l’autore per comprendere meglio il contesto di questo libro. Se non avete ancora idea della trama vi consiglio di leggere la nostra recensione. Siamo certi che questo contenuto saprà approfondire e al contempo incuriosire maggiormente tutti coloro che danno valore alla memoria e a tutti coloro che desiderano fermarsi e riflettere su come il passato sia legato al presente. Per capire gli altri e per capire, forse modellare noi stessi imparando.
Chi è Roberto Sciahinian? Ci dica qualcosa di lei. Dove vive, cosa fa, le sue passioni.
Come si può intuire dal cognome, sono di origine armena (tutti i cognomi armeni finiscono per “ian”, che è un patronimico). Mio padre era armeno (entrambi i genitori armeni. Il cognome di mia nonna era Barsamian), mia madre, invece, italiana, perugina per la precisione.
Erano originari di Sivas, l’antica Sebaste (o Sebasteia), nell’odierna Turchia.
La loro fuga dalla terra natale avvenne nel 1895, cioè a seguito delle persecuzioni di Abdul Hamid, il sultano rosso, rosso come il sangue dei cristiani che aveva fatto ammazzare.
Anche io sono nato a Perugia, dove tutt’ora vivo in una villetta immersa nel verde.
Le mie passioni, oltre che leggere (qualsiasi cosa, dai fumetti ai romanzi ai trattati e alle poesie) e, naturalmente, scrivere, sono il giardinaggio e il bricolage, cioè cose che mi impegnano fisicamente, dopo 40 anni di banca.
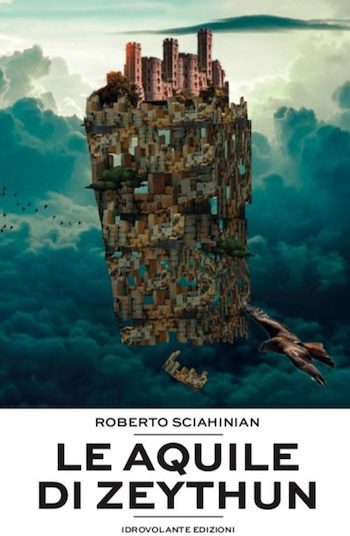 Titolo: Le aquile di Zeythun
Titolo: Le aquile di ZeythunAutore: Roberto Sciahinian
Pubblicato da Idrovolante Edizioni - novembre 2022
Pagine: 517 - Genere: Romanzo storico
Formato disponibile: Brossura
ISBN: 9791281143029
📗 Acquista scontato su ibs.it
📙 Amazon (spedizione gratuita)
📍 Comunicato - Booktrailer
🎬 La video recensione su Youtube
✪ Le recensioni dei lettori su Goodreads
"Era una cosa così eclatante che correva sulla bocca di tutti, suscitando stupore e ammirazione, almeno da parte degli europei. Che un manipolo di montanari male armati riuscisse a tenere in scacco per mesi un intero esercito dotato di armi moderne e di cannoni era qualcosa di epico, che meritava di trovare spazio negli annali di storia. Adesso però la situazione stava precipitando e le sorti di quella gente erano in serio pericolo".

Le aquile di Zeythun è il suo romanzo d’esordio. Lo abbiamo recensito sul nostro sito e ci è piaciuto molto. Lei riporta importanti fatti storici che coinvolgono la comunità armena, una ferita mai chiusa. Quando ha maturato la volontà di voler trattare l’argomento in maniera così approfondita? Perché ha scelto lo strumento narrativo del romanzo?
Possiedo un considerevole numero di libri che trattano del genocidio degli armeni del 1915; nessuno che riguardi le persecuzioni e i massacri compiuti venti anni prima, che sono poi stati la ragione per la quale la mia famiglia ha abbandonato la terra natia.
Parlare di quel periodo storico, quasi dimenticato dai più, è stata come una necessità che ho provato fin dalla mia infanzia, quando mio padre mi parlava dell’Armenia, delle sue tradizioni secolari e della sua fede.
Inoltre, la storia della resistenza di Zeythun, di cui avevo ascoltato da mio padre le eroiche imprese dei fedayi, mi ha sempre appassionato, inducendomi, non appena ne avessi avuto il tempo, a fare ricerche e ad approfondire l’argomento.
La scelta del romanzo come strumento narrativo mi è parsa scontata.
Quale obiettivo si è posto in relazione alla storia della minoranza armena?
Quando si parla di armeni, la prima cosa che viene in mente è il genocidio del 1915. Una storia mostruosa che ha visto l’uccisione di oltre un milione e mezzo di uomini donne e bambini. Un popolo mite, pacifico, inerme e cristiano, che è stato vittima della ferocia e dell’odio di un altro popolo.
Ma la storia di Zeythun è diversa ed ho ritenuto giusto che fosse portata a conoscenza di quante più persone possibile.
È un romanzo tutt’altro che banale. Forse si può definirlo un incontro tra tante storie, lì dove emerge la sua creatività. Poi c’è la commemorazione e la celebrazione della Storia che vanno oltre l’elencazione di fatti, dati e nomi che ci si attende da un romanzo storico. Saprebbe dirci qual è l’elemento in più, l’ingrediente segreto che ha usato per rendere queste storie palpitanti e toccanti?
Non credo di avere ingredienti particolari, tantomeno segreti, salvo la passione, il coinvolgimento emotivo e sentimentale.
Sciahinian è uno scrittore che crea personaggi e li dirige, oppure uno che incontra per caso un personaggio e lo segue?
Entrambe le cose. Normalmente sono io che creo i personaggi e li conduco fino in fondo. Può accadere che nello sviluppare la storia, la fantasia si imbatta in un personaggio interessante e che vale la pena di seguire.
Quale personaggio reale o fatto storico le è stato particolarmente di ispirazione, una guida, nella stesura del romanzo?
Sicuramente Aghassi, il capo della delegazione del partito Hnchak a Zeythun. Personaggio reale che è stato il promotore e l’organizzatore della rivolta.
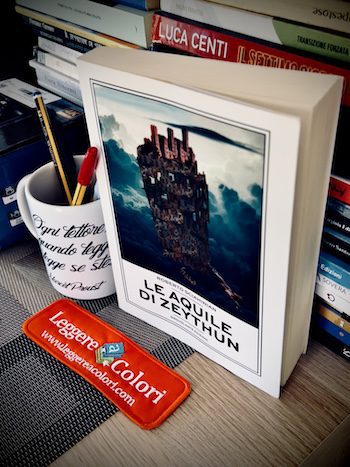 In che misura, secondo lei, conoscere la “questione armena” può essere utile anche ai lettori che non si sono mai interessati a queste vicende e che non sono, per così dire, addetti ai lavori.
In che misura, secondo lei, conoscere la “questione armena” può essere utile anche ai lettori che non si sono mai interessati a queste vicende e che non sono, per così dire, addetti ai lavori.
Paragonerei la “questione armena” alla “questione ebraica”, perché entrambe sono state oggetto di genocidio (parola coniata dal polacco Raphael Lemkin con riferimento a quello armeno). Con la differenza che mentre del secondo si è parlato e si continua a parlare moltissimo, di quello armeno, il primo genocidio della storia moderna, pochi sanno addirittura che sia avvenuto. Certo le due cose non sono paragonabili in termini di portata numerica delle vittime (6 milioni per gli ebrei contro i 2 milioni complessivi per gli armeni), ma sono pur sempre numeri spaventosamente elevati ed in entrambi i casi con l’intento dichiarato di cancellare una intera etnia.
Ritengo quindi che sia culturalmente interessante conoscere la storia, tutte le storie, se non addirittura doveroso.
La gestione delle informazioni, la diplomazia, la religione, la guerra: sono cambiati i mezzi ma le attitudini e i comportamenti sono simili a quelli di una volta. Leggendo il suo libro pare di vedere immagini recenti o attuali. Secondo lei l’uomo ha imparato qualcosa dagli errori e dal dolore del passato oppure dimentica troppo presto?
L’uomo è sempre lo stesso, fin dagli albori dell’umanità. Non solo non imparerà mai dagli errori commessi, ma ne farà sempre di peggiori.
Si pensava che certi crimini, certi abomini non potessero più essere commessi, ma basta guardare a quanto sta accadendo oggi in Ucraina, in Palestina, o, per quanto riguarda gli armeni, nel Nagorno Karabakh (Artsakh per gli armeni). L’avidità, la cupidigia, la totale insensibilità verso le sofferenze del prossimo, se queste sono necessarie per soddisfare le proprie brame, sono una costante nei comportamenti degli uomini, sempre più secolarizzati.
Una domanda difficilissima: quando, per un popolo, è giusto ribellarsi?
Credo che il mio libro abbia dato una risposta esauriente a questa domanda: quando i criteri di giustizia e di libertà che regolano i rapporti tra gli uomini, siano stati soppiantati da arbitrio, oppressione, ingiustizia.
Qual è l’eredità che ci ha lasciato Zeythun.
Dal mio punto di vista, la storia di Zeythun ha insegnato che l’uomo deve avere dei valori irrinunciabili, per i quali è persino giusto sacrificare la vita.
Fabio Pinna